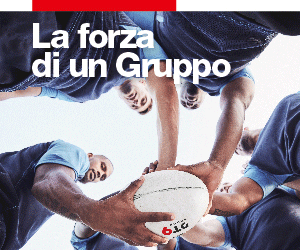La rassegna trimestrale del Parlamento sulla costituzionalità della leggi si concentra anche sul tema dei giochi.
Focus anche sulla sentenza n. 104 del 2025 in materia di divieto di installazione presso i pubblici esercizi di apparecchiature che consentano il gioco online, ne “Il controllo di costituzionalità delle leggi”, ossia la rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale di Camera e Senato, di cui è di fresca uscita e pubblicazione il terzo numero dell’anno, riferito al periodo luglio-settembre 2025.
La rassegna ovviamente nulla aggiunge a quanto già noto, ma analizza a fondo la sentenza della Corte costituzionale e le sue implicazioni.
Con la sentenza n. 104 del 2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
– dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
– e dell’articolo 1. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Le disposizioni oggetto della sentenza
L’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ha ad oggetto il divieto di installazione, presso i pubblici esercizi, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare sulle piattaforme messe a disposizione dei concessionari online, da soggetti autorizzati all’offerta di gioco a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo rilasciato dalle autorità competenti.
L’articolo 1. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede tra l’altro, la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
I motivi delle ordinanze di rimessione
Con due ordinanze, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha censurato, l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, appena sopra richiamato.
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., per il carattere assoluto e indiscriminato del divieto che colpisce la mera messa a disposizione anche di personal computer a navigazione libera, a prescindere dall’effettivo collegamento a siti di gioco online, in mancanza di un
ragionevole bilanciamento del diritto alla salute, sotteso alla disposizione censurata, con il diritto di libertà di impresa, nonché con il diritto alla riservatezza degli utenti. È denunciata, inoltre, la violazione dell’art. 25 Cost., per l’indeterminatezza della fattispecie che lascerebbe all’amministrazione un margine di discrezionalità del tutto contrastante con il principio di legalità nonché degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu e agli artt. 16 e 17 Cdfue, perché verrebbe sacrificato in modo irragionevole e indiscriminato il diritto di libertà di impresa, nonché il diritto alla riservatezza degli utenti.
La stessa Corte di cassazione e il Tribunale di Viterbo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hanno inoltre censurato l’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, che punisce, al primo periodo, con la sanzione
amministrativa di ventimila euro la violazione del divieto previsto dall’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Questa disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la fissità del trattamento sanzionatorio impedirebbe di tener conto della differente gravità in concreto dei singoli illeciti, con la conseguenza che la reazione sanzionatoria risulterebbe manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore dei fatti. Infine, è denunciata la violazione degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu e agli artt. 16 e 17 Cdfue, poiché i diritti di proprietà e di libera iniziativa economica sarebbero incisi secondo una costante predeterminata, che imporrebbe il medesimo trattamento sanzionatorio per condotte che, in concreto, potrebbero presentare significative differenze di disvalore.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha giudicato fondate le censure proposte dai remittenti in riferimento alla violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu e agli artt. 16 e 17 Cdfue.
Come correttamente rilevato dai giudici remittenti ogni apparecchiatura che consenta il gioco a distanza, quindi anche apparecchiature come personal computer o tablet collegati in rete, risulterebbero ricompresi nella disposizione normativa oggetto di censura. Tale genericità della disposizione comporta che vi sia una sproporzione tra l’esigenza di protezione della salute pubblica e di contrasto alla ludopatia, obiettivo dell’intervento normativo, e le modalità utilizzate per conseguire tale obiettivo.
La Corte rileva inoltre che occorre verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa a
tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia Ue, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).
In relazione a questo profilo, la disposizione censurata introduce infatti, rileva la sentenza, «una misura di tutela del diritto alla salute consistente in un divieto volto a fronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell’offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata
compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa».
Anche sotto questo profilo, secondo la Corte, l’estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge. Secondo la Corte, nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa.
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione e delle relative sanzioni.